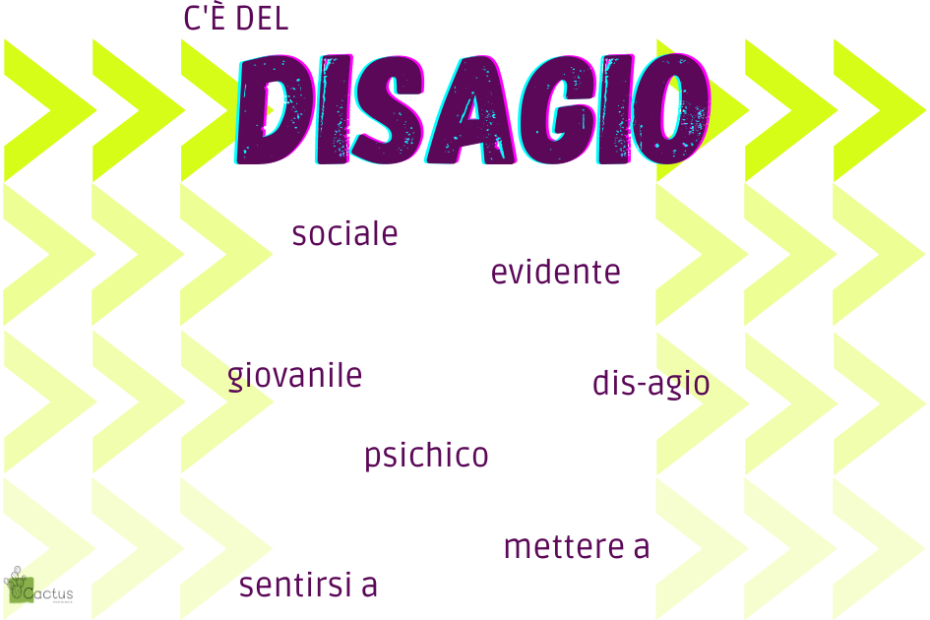La più grande ricchezza che la lingua possiede è quella di essere un animale vivo, che cambia e muta in dei modi non prevedibili e le parole assumono nel corso di epoche e periodi storici un valore nuovo e diverso che talvolta può consacrarle a simbolo di un momento storico o di una generazione.
Non a caso una parola che potrebbe rappresentare bene le generazioni Y e Z è disagio, che non a caso da semplice e specifica appendice di un determinato modo di sentire (“sentirsi a disagio”) relativamente poco utilizzato si è trasformata in un’esclamazione (“che disagio!”) o in un sostantivo e aggettivo (“la festa era un disagio unico”, “un tizio davvero disagi(at)o”) che dipinge uno scenario di sgradevolezza immediatamente comprensibile.

Sì, perché è innegabile che il disagio sia un’esperienza comune a tuttз e forse – nella sua precarietà affettiva, sociale ed economica a livello globale – la nostra (Y e Z) generazione potrebbe essere definita come la generazione disagio, ben rappresentata da un termine tradizionalmente “clinico” diventato parte dei discorsi di tutti i giorni.
Jonathan Franzen spiega molto bene questo sentire generazionale nel primo racconto del suo libro “Zona disagio”: in contrapposizione con la zona benessere verso la quale suo padre regolava il termostato ogni sera prima di andare a dormire, la zona disagio è quella in cui si è costrettз a confrontarsi con tutta una serie di emozioni, ricordi e sensazioni non piacevoli.
Franzen la sapeva lunga, anche se appartenente a un’altra generazione – e aveva anche un po’ precorso i tempi, considerando che il libro è del 2006.
Ma cosa vuol dire disagio?
Interpellando come sempre l’autorità della Treccani emerge questo:
diṡàgio s. m. [comp. di dis– e agio]. – a. Mancanza di agi, di comodità e sim.; condizione o situazione incomoda: soffrire, patire, sopportare disagi di ogni specie; affrontare i d. di una lunga navigazione; stava a d. in quella sedia troppo stretta per lui. b. Senso di pena e di molestia provato per l’incapacità di adattarsi a un ambiente, a una situazione, anche per motivi morali, o più genericam. senso d’imbarazzo: è un luogo, una compagnia, in cui mi trovo a d.; quei discorsi misero a d. tutti i presenti; davanti a lui mi sento sempre a d.; il suo modo di guardarla la metteva a disagio.
Anche dalla definizione è come se emergessero due piani: un piano più reale e condiviso, una “mancanza” oggettiva di agi e comodità, e un piano più interno, più intimo, in cui la persona si trova a confrontarsi con un senso di mancanza e di non adeguatezza che però sembra che all’esterno non sia immediatamente afferrabile (nota polemica: manco dalla Treccani che utilizza il termine affilato di incapacità).

Ma quindi esistono un disagio di serie a (quello concreto) e un disagio di serie b (quello interno)?
La risposta è ovviamente no, perché per quanto si possano teoricamente distinguere i due piani, nella letteratura psicologica il termine disagio implica una condizione in cui il benessere psicologico viene limitato o da una mancanza concreta di alcune componenti necessarie alla vita o da una sensazione interna che impediscono alla persona di stare bene.
La condizione di disagio può andare da un’esperienza lieve e/o transitoria a una sensazione invece pervasiva e/o prolungata ed è effettivamente il fatto che sia clinicamente significativa a determinare se siamo o no in presenza di un disturbo vero e proprio.
Ad esempio, ci si può sentire a disagio quando si deve parlare di fronte all’intera classe e questa cosa è legata specificamente a quel tipo di situazione, in cui si è al centro dell’attenzione, oppure una simile condizione di disagio si può provare costantemente anche in situazioni in cui non si è al centro dell’attenzione ma ci si sente comunque osservatз e giudicatз.
Ma chi dice quanto è significativo il disagio?
Per fortuna – o purtroppo, a seconda delle situazioni – non c’è una polizia del disagio ed è uno di quei rari casi in cui l’esperienza soggettiva è più importante dell’oggettività.
Nel DSM, Manuale dei Disturbi Mentali che è oggi alla sua quinta edizione, in molti disturbi risulta essere un vero e proprio criterio diagnostico il fatto che la persona rispetto ai sintomi provi un “disagio clinicamente significativo o/e compromissione del funzionamento lavorativo, sociale o in altre aree importanti”: il che vuol dire, in controtendenza con tutta una serie di norme e convenzioni del mondo in cui viviamo, che sta a noi decidere qual è il nostro limite e fino a che punto il nostro disagio è ok oppure merita di essere preso in considerazione e curato (nel senso che qualcuno possa prendersene cura).
Il che è ovviamente una notizia bellissima (ma anche un po’ disagiante), perché come sempre da grandi poteri derivano grandi responsabilità e prenderci cura del nostro benessere (e del nostro disagio), monitorarci costantemente e chiederci come stiamo e se abbiamo bisogno di un aiuto non è semplice.
Sicuramente però possiamo imparare: possiamo provare a stare un po’ nel nostro disagio, ascoltarlo e sentire che cosa ha da dirci anche perché a volte è proprio la scomodità a darci i suggerimenti migliori su chi siamo, dove siamo e dove vogliamo andare.